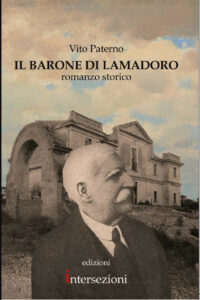 Il barone di Lamadoro, romanzo storico di Vito Paterno.
Il barone di Lamadoro, romanzo storico di Vito Paterno.
L’autore ci ha rilasciato una breve intervista in cui rivela qualche retroscena utile alla comprensione del suo romanzo di esordio.
Cosa ha voluto raccontare con questo libro?
Il mio è un racconto di emigrazione. I protagonisti di questa storia sono migranti interni: artisti, intellettuali, politici, professionisti, tutti pugliesi; una élite aristocratico-borghese approdata nella Capitale in cerca di quell’affermazione che l’Urbe sembrava prometterle. Un flusso ininterrotto verso Roma, accesosi al tramonto dell’Ottocento, subito dopo l’unificazione d’Italia, mentre si spegneva quello secolare verso Napoli. Nacque così una fiorente associazione di corregionali, una sorta di piccola appendice della terra di origine che ho cercato di ricostruire nella sua luce più autentica e genuina.
Nel secondo dopoguerra importanti pellicole cinematografiche del Neorealismo hanno rappresentato l’attrazione della grande città. Le lusinghe della sua dolce vita, il miraggio di raggiungere l’agognato benessere innescarono l’esodo di massa delle popolazioni del Mezzogiorno in fuga dalla povertà e da un’atavica arretratezza. Penso a Il cammino della speranza (1950) di Pietro Germi, a I basilischi di Lina Wertmuller (1963), a Rocco e i suoi fratelli (1961), capolavoro di Luchino Visconti al quale ho sottratto le parole che si odono dalla bella voce solista di Elio Mauro nella canzone che apre e chiude il film. Paese mio è un canto popolare, musicato da Nino Rota con la melodia di un’antica nenia tramandata oralmente dai fedeli del santo Nicola protettore
di Bari; è un’ode malinconica e sofferta, intonata al paese natio abbandonato e forse perduto per sempre. È conosciuta anche come Canzone Barese nella più recente esecuzione orchestrale del maestro Muti. Proprio gli ipnotici versi dialettali di Giandomenico Giagni campeggiano come un manifesto all’apertura nel mio romanzo, quasi a voler fornire una chiave interpretativa e sembrano aleggiare, nemmeno poco velatamente, in tutta la trama.
Il barone di Lamadoro è un grande affresco degli anni Venti del Novecento ambientato in una Roma ancora immersa nella dimensione incantata della Belle Époque. Un quadro idilliaco che però lentamente si dissolve con l’avvento della dittatura fascista. Come una macchina da presa il romanzo offre inquadrature in campo lungo, entra negli spazi urbani e negli eleganti interni di
sontuosi palazzi romani; essi fanno da sfondo ai dialoghi di uno stuolo di personaggi che potrei definire avanguardie della cultura e del ceto dirigente regionale. Nei luoghi dai quali partirono sarebbero divenuti autentiche glorie locali e con l’andar del tempo gli avrebbero intestato biblioteche, scuole, piazze, vie. Duole constatare che oggi i loro nomi sopravvivano da perfetti
sconosciuti nella più generale indifferenza. Nel contempo il romanzo rivolge uno sguardo verso la nostra terra, la cui denominazione era allora declinata al plurale in “Le Puglie”. Ritrae paesi rurali che furono teatro di tumulti per la fame e di tristi episodi originati dalla miseria diffusa in quegli anni di grandi rivolgimenti sociali e ammalianti utopie. Si stagliano su quell’orizzonte temporale feroci lotte tra braccianti e agrari; uno scenario nel quale maturò l’assassinio Di Vagno, precursore a sua volta del delitto dell’altro socialista Matteotti, che nel romanzo è ricostruito con una inedita angolatura.
Come un pittore che si allontana dal quadro di qualche passo dopo aver lasciato la sua pennellata sulla tela perché, riguardandolo a distanza, cerca di cogliere meglio l’effetto complessivo, allo stesso modo da lontano ho cercato di rileggere la recente storia passata della mia terra. Dal di fuori potevo cogliere una visione d’insieme, di sintesi, e la Capitale, dove si decidono le sorti anche del più piccolo lembo d’Italia, è stata un punto di osservazione assai congeniale. Spetta però al lettore giudicare l’esito di questo ambizioso proposito.
Come è nata l’idea del romanzo?
Il romanzo è stato una strada nuova, inaspettata. Non sapevo esattamente se fosse il genere letterario più adatto al mio disegno letterario. Ancor più complicata era poi la scelta di dover narrare fatti realmente accaduti. Credo sia stato un tentativo sentimentale.
Innanzitutto durante la mia permanenza nella città eterna ho lungamente frequentato l’ambiente dei circoli regionali. Ancora oggi esiste un circolo animato da una intraprendente comunità di pugliesi, nostalgici della terra d’origine. Evidentemente non è quello del quale si parla nel racconto, giacché fu costituito alla fine degli anni Quaranta. Come spesso accade in emigrazione, la lontananza fa riscoprire le proprie radici, amplifica maggiormente il senso di appartenenza e spinge sconosciuti all’aggregazione con conterranei.
L’ispirazione di affidarmi alla scrittura è balenata mentre mi aggiravo nell’Archivio Storico Capitolino. Durante le mie visite nel complesso borrominiano dell’Oratorio dei Filippini, che conserva fascicoli di progetti tardo-ottocenteschi necessari alle pratiche edilizie, ho subìto la fascinazione della ricerca storica. I silenziosi corridoi che si rincorrono attorno all’aranceto e la sala ovale della biblioteca sono popolati di studiosi provenienti da diverse parti del mondo. Mi sono trovato in compagnia di ricercatori di professione che sfogliavano antichi codici e manoscritti medioevali. Lì sono stato contaminato dal loro interesse, da quello spirito indagatore che riuscivo a scorgergli negli occhi, nell’atteggiamento immersivo da compulsatori di memorie. Ad un tratto, tra quelle polverose scaffalature c’ero anch’io a fronteggiare pile di documenti, file disordinate di faldoni, fogli sparsi appartenuti a chissà quali autori, in un ambiente vecchio che sa di fragile, di precario, di muffa. In fondo, come loro, mi occupo ormai di portare alla luce frammenti di cose passate, liberandole dalle incrostazioni del tempo.
Può spiegarci la scelta del titolo?
Non volevo scrivere un libro su di un personaggio in particolare. Avevo iniziato la compilazione di decine di schede anagrafiche a partire da un elenco di nomi rintracciati in vecchie «Guide Monaci» dell’Urbe. Cercavo, tuttavia, un soggetto paradigmatico, trasversale, che avesse attraversato l’intero periodo di vita del Circolo Pugliese; un testimone oculare che avesse potuto registrare le sue
vicende in prima persona. L’arco temporale del racconto coincide con gli anni novecenteschi di quest’uomo mite e saggio, nato nella prima metà del secolo precedente. La scelta del barone è stata strategica per la narrazione. Egli è un personaggio centrale, uno dei maggiori politici dell’età giolittiana, guida indiscussa della colonia romana di pugliesi. Alla sua vita s’intersecano quelle di
altre personalità, talvolta in un raffronto dagli esiti impietosi.
Il titolo ci dice che c’è un protagonista principale del racconto, ma lo lascia ancora circondato da un alone di mistero. Fornisce solo due indizi: un titolo nobiliare e un luogo apparentemente immaginario, che rappresenta una località reale ben precisa, un toponimo storico del territorio tranese; esso allude anche a una caratteristica morfologica ricorrente nella Terra di Bari, ovvero agli antichi fiumi fossili che solcano il nostro paesaggio. Le due coordinate geografico-temporali sono dunque collocate di proposito nel titolo per suscitare curiosità e lasciare spazio al lettore nel suo percorso di avvicinamento all’identità del protagonista principale, che lentamente si paleserà durante la lettura. Allo stesso modo anche la finzione del “racconto ritrovato”, di cui si parla nel Prologo, è stato un espediente per non arrovellarmi nell’interrogativo di dover o meno citare l’interminabile lista di fonti e documenti consultati e immergeva il racconto in quell’atmosfera giallista più affine al lettore generico. Ma, come ho detto, nel titolo non si esaurisce tutto il
contenuto del racconto. Non è una sola biografia, ma più biografie in una.
Da dove nasce il suo interesse per il barone.
Il mio protagonista, originario di Altamura, è un personaggio epico, un epigono del Risorgimento, un garibaldino della prima ora con il culto del “mito federiciano”. Combatté l’esercito napoletano sul Volturno, fu nel corpo diplomatico di Camillo Benso conte di Cavour. Per la verità il temperamento ardimentoso è una costante in tutta la storia della numerosa famiglia Melodia,
espressione di una secolare nobiltà feudale. Suo padre e i suoi fratelli, come lui, inseguirono il sogno di Dante di una penisola italiana finalmente riunificata. Suo nonno Vincenzo visse l’esperienza giacobina che infiammò illusoriamente il Mezzogiorno sull’onda emotiva della rivoluzione francese. Fu uno degli artefici della breve stagione repubblicana cittadina del 1799, finendo ramingo e poi sotto processo per aver cospirato contro i Borbone.
Per me il barone, che appare nel racconto già in età molto matura, non era un personaggio affatto nuovo. Molti anni fa con colleghi d’università mentre perlustravo le desolate ondulazioni dell’Alta Murgia, il cui paesaggio dall’aspetto romantico è ancora quello che percepiva il viaggiatore del secolo scorso, quel nome lo avevo già trovato. Ricorreva nei tanti toponimi, nella vetusta masseria nei pressi della Rocca del Garagnone, nei tanti possedimenti che costellano l’intero altopiano, nel monumentale palazzo della piazza principale di Altamura, di fronte proprio al duomo di Federico II.
Egli apparteneva alla grande proprietà terriera, ai maggiori latifondisti murgiani degli ultimi secoli. Quello che non conoscevo (l’ho scoperto solo recentemente) è il settecentesco Casino Lamadoro, dove visse, con sua moglie Concetta e una larga prole, le sue vacanze estive. Ridotto oggi allo stato di rudere, diroccato, con le coperture sfondate, i piani crollati, le tappezzerie distrutte, completamente spogliato del prezioso apparato decorativo, domina solitario, con la sua imponente sagoma, l’immenso vallone di Lama Cupa, tra Andria e Corato. Ne ho percepito subito gli echi del suo passato. Come un rabdomante ho cercato di captare tracce di presenze lontane, di vite dissolte che una volta avevano animato le sue grandi stanze racchiuse fra solide mura. Ho immaginato quale fosse la cultura al tempo del barone, quali libri potessero giacere allineati sugli scaffali della sua biblioteca di fine Ottocento, generi, titoli, autori, edizioni. Così in questa sorta di anamnesi mi è parso di essere un uomo del Risorgimento.
C’è un preferito tra i personaggi del libro?
I personaggi del racconto sono descritti secondo sfumature che corrispondono ovviamente a una scala valoriale; qualcuno appare abbozzato, delineato appena, qualchedun altro emerge con una immagine vibrante. Al lettore sembrerà evidente la mia simpatia verso taluni e la disapprovazione
del carattere di talaltri che non potevo tratteggiare se non a tinte fosche. Così si ritrovano in questo stesso romanzo storico l’altro altamurano Ottavio Serena, i garganici Petrucci, Vocino, Simone e i fratelli Chieffo. Il principe di Cassano, l’uomo in frac al centro del drammatico episodio iniziale sul ponte Milvio, in una scena di grande impatto emotivo che ci rievoca vagamente il brano Meraviglioso di Domenico Modugno, svela un senso intimo di inesplicabilità, di sgomento, una poco dissimulata pietas. L’alter ego del protagonista principale è Peppino. Contrariamente alla sua esile figura, egli è personaggio muscolare, spavaldo; incarna lo spirito della nascente stagione politica; è un capo mazziere, il fondatore del fascio di combattimento di Cerignola che guidò la marcia degli squadristi meridionali verso Roma. Confesso di aver provato, invece, sentimenti profondi verso il magistrato originario di Deliceto, piccolo borgo del Subappennino Dauno. Una simpatia forse indotta dalla sua generosità, dalla sua filantropia. Questo è stato il mio sentire nella ricostruzione del personaggio sulla base delle notizie raccolte, a proposito delle quali voglio ringraziare l’avvocato Mattia Iossa. Con lui mi scuso per averne così a lungo sollecitato la memoria, dalle cui profondità è riuscito a tirar fuori nomi, luoghi, storie, tradotte poi in immagini e vere e proprie sequenze cinematografiche. Chieffo sarà, in seguito, protagonista di una fuga rocambolesca dalla giustizia sommaria dei postfascisti. Venne prosciolto dall’accusa di peculato, reato di cui si sarebbe macchiato durante il suo incarico di capo di gabinetto ricoperto sotto il ministro Edmondo Rossoni. Ma questa è un’altra storia. Le note biografiche non sono didascaliche neppure per Mauro del Giudice, altro magistrato garganico del Palazzaccio di piazza Cavour, giudice istruttore proprio del caso Matteotti. La sua inchiesta, che fu sul punto di far crollare le fondamenta del credo mussoliniano, fu inizialmente una specie di partita giocata in seno al Circolo Pugliese prima che l’anziano rodiese fosse espulso come una impurità dal sistema corporativistico e ideologico del littorio.
In questa mia opera prima di genere romanzesco ciascun personaggio vive una condizione esistenziale divisa tra l’avvolgente modernità della città e il ricordo della terra lontana con i suoi rituali semplici, arcaici, identitari; un percorso evocativo che sembra tuttavia irrimediabilmente escludere ogni possibilità al ritorno.

